Oggi inizierò parlando della mia
autoradio. Sapete, quella cosa con cui si ascoltano i dischi in macchina,
residuato bellico per chi ormai si compra una macchina nuova da qualche anno a
questa parte visto che c’è il computer di bordo. L’autoradio me l’hanno fregata
due volte, ho rischiato anche che me la fregassero una terza ma i simpatici
ladruncoli che mi hanno aperto la Uno si sono accontentati di uno zaino con le
mie mutande (non crediate di essere al sicuro voi tecnologicamente avanzati,
fregano anche i computer di bordo, ad un mio amico è successo). Ora non ho più
una Uno ma una fantastica Seat Ibiza, bicolore perché sono andato in culo ad
uno e con una fiancata rigata per vari motivi (non ultimo il cancello della
ditta dove lavoro che ha cercato di entrarmi in macchina), ma visto che i
computer di bordo dieci anni fa erano ancora una cosa costosa ho sempre
un’autoradio, però con la chiavetta usb. Ora, cosa c’entra tutto questo con gli
Intercity? Cosa hanno fatto di male per meritare un cappello introduttivo così
idiota? In realtà hanno fatto solo del bene, e lo shuffle in macchina ha fatto
bene a loro: perché Amur è un album fra i migliori ascoltati in tutto l’anno,
ma ad attirarmi particolarmente è stato il fatto che fra tutte le canzoni che
poteva scegliere la mia autoradio da far partire a caso ha scelto Teatro Sociale e Kyoto, probabilmente le migliori del lotto.
La storia degli Intercity parte
da lontano ed è stato con un certo stupore che ho scoperto il loro legame
diretto con gli Edwood, gruppo ascolticchiato
negli anni 2000 di cui ho sempre adorato il nome (se non sapete da cosa deriva
non siete degli appassionati di cinema trash d’annata come il sottoscritto). Una
bella rivoluzione è intercorsa dal precedente Yu Hu, tanto che solo la base
storica dei fratelli Campetti (Fabio
voce e chitarra, Marco all’altra chitarra) è rimasta a tenere alta la bandiera:
ecco così che, pur mantenedo un legame col passato tenuto saldo soprattutto
dalla voce pacata di Fabio, si trovano strade nuove che passano soprattutto dal
violino di Giulia Mabellini. E’
infatti questo l’elemento che più mi ha colpito, inserito negli arrangiamenti
in maniera precisa e funzionale, non un orpello estetico messo lì per fare
numero (mi è capitato di sentire band che lo fanno, fidatevi) ma un elemento
essenziale afruttato tanto bene quanto non mi capitava di sentire da quando mi
capitò fra le mani il secondo disco degli Io?
Drama. E’ anche grazie al suo apporto che momenti più zoppicanti come la
ripetitiva Tu acquistano più valore,
o che episodi già di per sè validi come la già citata Kyoto assumono, nei ritornelli, una valenza emozionale quasi
commovente. E questo è solo uno dei pregi del disco.
Perché, violino o no, Amur è
pieno zeppo di bei pezzi. Prendi il ritmo in levare di Reggae Song, che tutto porta alla mente con la sua atmosfera
nostalgica tranne che le assolate spiagge caraibiche (“nuovi Don Chischotte
ascoltano reggae”, pur nella sua stranezza, è una frase che mi metto a cantare
ogni volta che la sento), la carica elettrica esasperata dal basso distorto e
dalle voci confuse di Cavallo,
l’andamento in crescendo continuo di Teatro
Sociale, la malinconia palpabile di Amur,
la grinta dei ritornelli di A...gli
esempi positivi sono talmente tanti che si fa prima a dire cosa non funziona. Il
finale fin troppo morbido con Le
Avanguardie, ad esempio, un modo di concludere il disco che lascia un poco
l’amaro in bocca, o l’esagerazione in qualche caso di effetti sulla voce che
rendono confuse le linee vocali (Cavallo,
particolarmente nei ritornelli, ne è l’esempio più lampante, ma anche le doppie
voci dell’iniziale Un Cielo Cinghiale
nella seconda parte presentano marcatamente lo stesso difetto, spiacevole dal
punto di vista della comprensione dei testi ma assolutamente efficace come
carica adrenalinica): la voce di Fabio, invece, funziona ottimamente col suo
tono naif fra un Bianconi ed un Colapesce, riuscendo abilmente a variare
intensità fra le note acute dei ritornelli di Indiani Apache, il tono mellifluo di Amur e la grinta sfoggiata ad esempio in Cavallo e nei ritornelli di A.
Parlando ieri con un ragazzo
conosciuto ad un concerto ricordavo una recensione, scritta un paio d’anni fa,
dove mi “lamentavo” di un disco dicendo che era un peccato che mi fossi già
giocato l’album dell’anno a gennaio. Amur arriva invece come la lieta sorpresa
di fine anno, ed è valsa la pena che le mie orecchie attendessero tanto per
goderne: arrangiamenti ottimi, varietà musicale che non pregiudica l’improsi di
uno stile personale, liriche accattivanti che, pur con qualità altalenante, ti
entrano subito in testa senza volerne uscire. Mi gioco le cinque stelle perché,
rileggendo quanto scritto, mi accorgo che non ho potuto dire molte volte negli
ultimi anni le stesse cose di un disco, e me ne compiaccio molto.
Voto: ◆◆◆◆◆
Label: Orso Polare Dischi


 16:24
16:24
 FickyIZ
FickyIZ











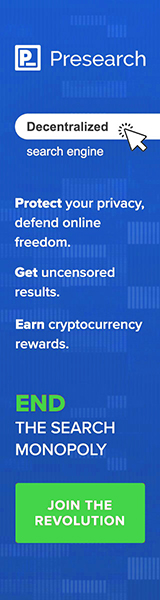
0 comments:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.